SOSTIENI L’ASSOCIAZIONE BELLUNESI NEL MONDO. DIVENTA SOCIO
Il 2021 è stato l’anno dedicato al settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri. Voi avete mai letto almeno un canto della Divina Commedia? Quanti di voi si ricordano a memoria i versi dei canti? Li capite senza problemi? O avete bisogno delle dettagliate spiegazioni scritte da esperti dantisti? Conoscete tutti i personaggi e le vicende che si intrecciano nella complessa opera dantesca? Credete veramente che Dante fosse un purista quando decise di usare la lingua volgare per scrivere la sua opera?
Io ho dovuto leggere diversi canti della Commedia al liceo. Ho sempre avuto un ricordo piuttosto contraddittorio di quelle letture risalenti a un periodo piuttosto strano della mia vita. I motivi sono molteplici. Cito solo una certa dose di disinteresse adolescenziale per le vicende scolastiche e la sostanziale mancanza degli strumenti critici necessari per capire il mondo descritto da Dante.
Quando mi sono trasferito in Svizzera ho portato pochi libri dall’Italia. Tra questi c’erano i tre grossi tomi della Divina Commedia che avevo al liceo. Li ho messi sullo scaffale insieme ad altre pubblicazioni più consone ai miei interessi accademici. Per lunghissimo tempo ho sempre evitato di aprirli.
Alcuni anni fa un’istituzione elvetica che si occupa della formazione degli adulti mi chiese se fossi disponibile a fare una serie di lezioni sull’opera dantesca. Non potevo rifiutare. E così presi coraggio e riaprii quei libri. Ritrovare le mie annotazioni, scritte a margine del testo, fu come ricevere un pugno nello stomaco. A cosa pensavo in quegli anni giovanili? Mah…!
La rilettura di Dante da adulto mi ha permesso di fare un incredibile viaggio nell’Italia medievale. È impossibile menzionare qui tutti i luoghi citati dal Poeta. Feltre, comunque, è ricordata nel canto IX del Paradiso (versi 52-54).
Ho scoperto anche che le mie esperienze di vita mi permettevano di comprendere meglio certi stati d’animo del poeta. Chi di noi non ha mai sognato di mandare pubblicamente al diavolo le persone che ci stanno antipatiche e di salvare quelle che amiamo? L’originalità di Dante è stata quella di avere fatto questa operazione, scrivendo versi densissimi di metafore, non sempre comprensibili senza le adeguate chiavi di lettura, e usando un suo idioma che, in seguito, è diventato anche la base della nostra lingua nazionale.
Personalmente non ho mai considerato il poeta fiorentino come il mio totem sacro e intoccabile. Non ho mai amato nemmeno le frasi retoriche sulla cosiddetta “lingua di Dante”, oggi corrotta dagli anglismi e da salvare in nome della purezza culturale. Ho preparato le mie lezioni cercando di evitare l’enfasi che, spesso, viene usata nelle citazioni dei versi del Poeta e, forse, l’ho reso così anche un po’ più umano.
Un giorno si avvicina una persona che ha frequentato i miei corsi che mi consegna un piccolo pacchetto.
“È un regalo per ringraziarti”, mi dice.
Lo apro e trovo quattro antichi libretti. Scopro che si tratta della Divina Commedia in versione tascabile edita a Venezia nel 1833. Stanno nel palmo della mia mano. La persona aggiunge che apparteneva al nonno, collezionista di libri antichi. Alla morte dell’avo la collezione è stata venduta, ma quell’edizione dell’opera dantesca è rimasta nello scaffale dei libri di famiglia. Questa persona ha imparato i primi rudimenti della lingua italiana proprio con quella edizione della Commedia.
Adesso questi libretti si trovano nella mia libreria personale, in prima fila, insieme a quelli del liceo. Sono diventati il mio totem personale.
Raffaele De Rosa





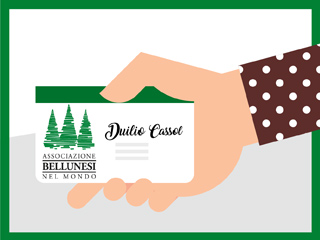






0 commenti